C’è un tratto che accompagna la mia quotidianità da una decina d’anni a questa parte: la precarietà. Quando l’ho conosciuta per la prima volta ho pianto. Era un pianto che arrivava dritto dalla pancia, era un pianto di disorientamento, come quello di un bambino che non trova più la mamma in spiaggia a Ferragosto. Però c’era anche un pizzico di celata curiosità per l’ignoto, di compiaciuta incoscienza e di consapevolezza di essere solo un neofita, un dilettante allo sbaraglio della precarietà. Avevo paura. Eccome se ne avevo, una paura che mi rallentava i passi e i battiti cardiaci, ma non mi fermava.
Ora ho fatto strada. Nella mia precarietà mi muovo sicuro. La sento, la assecondo. La assecondo anche quando mi toglie il sonno, quando mi fa sfiorare la crisi di panico, quando riesce a farmi partire una raffica di pensieri che, in pochi secondi trasformano, un piccolo incidente di percorso nella causa suprema della mia fine imminente.
Nell’Italia Rossa la precarietà è diventata la regola. Non so quanto durerà la quarantena, se mi ammalerò o se mi sono già ammalto a mia insaputa, se è meglio la mascherina o bere direttamente l’amuchina, se posso correre al parco, o se posso farlo solo con un cane, e che cane.
Non so più che forma ha la famiglia. A quanti di noi sta capitando?
Spesso gli affetti sono divisi in luoghi diversi e a volte un isolato può diventare grande quanto quattro fusi orari. E non sai quando abbraccerai di nuovo tuo fratello, figlio, amico. Non sai nemmeno quando potrai di nuovo piangere a un funerale o ubriacarti a un matrimonio.
Non sai, non so, quasi più nulla di ciò che sapevi, sapevo fino a due settimane fa.
Fino a quando? Per poco, dicono.
Poco: unità di misura che solo chi è un esperto di precarietà sa misurare.
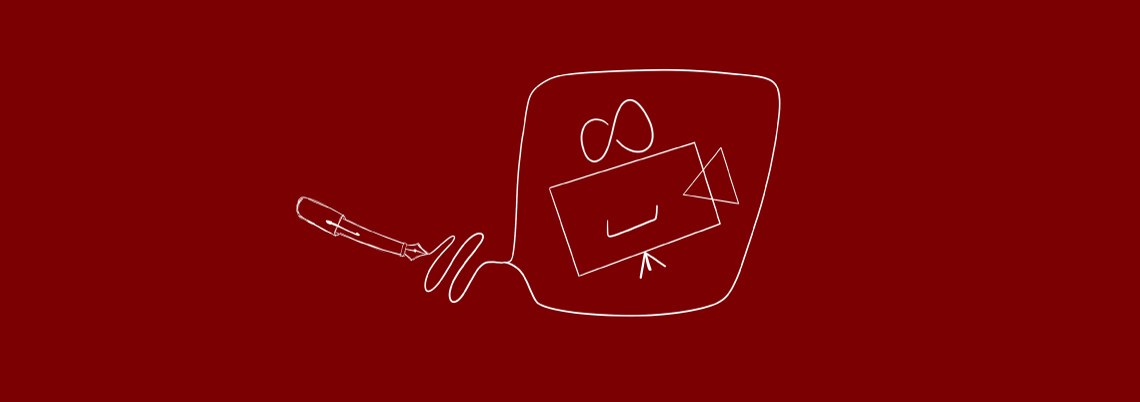

Tutta la mia vita lavorativa è stata nel segno della precarietà dovrei essere altro che esperta e invece manco riesco a immaginare cosa vorrà dire “poco”
🙂 lo scopriremo a breve, temo cara Dede