Ho intervistato Pietro a giugno. L’ho fatto prima di tutto perchè avevo bisogno di fare i conti con la mia storia. Abbiamo chiacchierato per più di due ore. Ho preso appunti, ascoltato, registrato sul mio iPhone. Poi mi sono fermato, senza una regione chiara. Ho iniziato a scrivere questo pezzo una decina di volte, mai più di un paio di paragrafi. Cancellavo. Avevo trovato le risposte che cercavo e mi bastava? Forse. E poi: come si può raccontare un cerchio che si chiude? Sei mesi dopo quell’intervista è giusto almeno provarci. Glielo devo. Me lo devo. E lo devo a mio padre.
Conosco Pietro dal 1980 (poco più, poco meno), ma ci diamo del tu solo da qualche anno. È il papà di E., alla quale mi lega un’amicizia vera e profonda iniziata all’ombra del campanile di una chiesa.
Pietro è stato quello che in sintesi si può definire un “uomo Fiat” nel senso stretto della parola. Dalla scuola di corso Dante fino a responsabilità dirigenziali importanti, dal 1959 al 2009. Mio papà, invece, era operaio nel reparto carrozzeria di Mirafiori, addetto alla manutenzione. Lo è stato dal 1964 fino alla pensione. La Fiat era allora un “posto fisso”, come quello alle poste.
Sulla carta era il nemico di classe. Eppure tanto mio padre che Pietro non hanno mai detto una parola sul fatto che E. ed io ci frequentassimo, che andassimo in vacanza insieme, che condividessimo molto del nostro tempo. Rappresentavamo, senza esserne davvero consapevoli, due Torino diverse e contrapposte che, è bene ricordarlo, si combattevano duramente. Gli anni erano quelli di piombo e i dirigenti della Fiat erano un obiettivo militare delle Brigate Rosse.
A distanza di tempo e di fronte allo sgretolamento del mondo che è stato sia di Pietro che di Rocco, avevo bisogno di sapere cosa ne pensasse. Il 2024 è stato forse l’anno più buio per la storia di quella che oggi chiamiamo Stellantis e che è stata un tempo la Fiat. Nei vari stabilimenti italiani sono stati prodotti solo 300 mila veicoli. Come nel 1956.
Riavvolgiamo il nastro fino al 1953. Siamo a Torino, Pietro ha 10 anni, un fratello e un papà che già lavorava alla Fiat. “Sono un figlio della guerra. – racconta – Ti parlo di una Fiat che ho amato e benedetto. Quella dell‘assistenza sanitaria, delle colonie per bambini, degli asili nido, delle case. Se ti dicessi che la mia famiglia era povera in canna non renderei l’idea. Il venerdì spesso non si mangiava fino a quando papà non portava a casa l’anticipo della paga.“
In quella città stravolta dai bombardamenti e dalla guerra civile la fabbrica degli Agnelli assunse un ruolo diverso da quello avuto fino ad allora. “Quello che ha fatto la Fiat per noi in quegli anni è ciò che nei paesi dell’Est Europa hanno fatto i regimi comunisti per le loro aziende fino alla caduta del muro di Berlino. Si è costruito un modello che dava grandi benefici ai lavoratori e creava fidelizzazione. Funzionava molto bene. A metterlo in crisi sono state le prime lotte sindacali, quelle più radicali.”
Le antenne si drizzano. Rocco, mio padre, era un sindacalista di area socialista. Non ha mai legato con la Fiom, ma insomma… “Non era un modello di sfruttamento, come si diceva, anzi. A smontarlo, un pezzo alla volta, è stata la politica, che aveva bisogno del consenso e del voto degli operai. Così facendo però ha reso rapidamente la Fiat incapace di competere sul mercato. Credo che l’Avvocato sia stato tra i più determinati a credere ancora, nonostante tutto e fino all’ultimo, in quel modello di fabbrica. Chiunque altro, al posto suo, sarebbe andato via da questo Paese a fine anni sessanta.“
Accuso il colpo. Seguo il filo logico di Pietro che mi conduce su un terreno per me nuovo: “Le vie di fuga Gianni Agnelli le ha cercate, intendiamoci. Le fabbriche costruite in Brasile, Polonia, Serbia, Turchia, Marocco erano necessarie. Erano aziende nelle quali era più facile lavorare e l’utile che proveniva da lì, copriva i problemi della Fiat italiana.”
Questo è il terreno di Pietro, che ha passato molti anni all’estero. “Quando sono andato in Polonia, nel 1992 e l’azienda di Stato è diventata a tutti gli effetti della Fiat, introducendo le proprie regole, non fu affatto facile. Era un Paese dove in un appartamento vivevano due o tre famiglia, dove non esisteva autonomia decisionale o strategia produttiva. Però lì si costruivano motori piccoli per auto piccole e nessuno al mondo sapeva farle come Fiat.“
A Biesko-Biala Pietro, come responsabile della qualità di undici stabilimenti, rimette in piedi la linea della Fiat 126 e avvia quella della Cinquecento prima e della Seicento poi, vetture che risollevarono le sorti della Fiat in Italia. “Volevo che tutti si sentissero responsabili e partecipi di ciò che stavamo producendo, che è l’unico modo per fare un prodotto finale vincente. Funzionò. A me piaceva andare in linea, confrontarmi con gli operai, verificare con loro eventuali aggiustamenti. In Italia non sarebbe stato possibile.”
Un’altra stoccata pesante. “L’operaio qui era, in qualche modo, intoccabile. La direzione poteva licenziare me, senza battere ciglio. Non certo un operaio. Si sarebbe scatenato il finimondo. Per cui mi stupisco che quella Fiat abbia resistito così a lungo.”
Mentre cerco di metabolizzare, Pietro mi lancia una scialuppa di salvataggio. “Poi ci sono gli errori, anche gravi, da parte di Fiat. Penso prima di tutto a Cesare Romiti e all’idea assurda di produrre qualunque cosa, ma poche automobili. Una chiara mancanza di cultura industriale.” Subito dopo una seconda scialuppa. “E poi sai una cosa? Non ho mai amato la globalizzazione.” Lo guardo stupito. “Me la sono vissuta tutta ed è stata una diavoleria infame. Prendevamo i motori in Argentina, e non arrivano mai. E farli arrivare costava una quantità enorme di denaro. Che senso aveva?“
La globalizzazione, sembra preistoria. E Sergio Marchionne? “Lui è entrato mentre io uscivo, l’ho conosciuto poco, ma era bravo. Dispotico certo, però sapeva il fatto suo e scegliendo di vivere a Torino ha dato un segnale. Infatti la Fiat dopo Marchionne non è più stata la Fiat di Torino.“
Mentre Pietro si racconta comprendo che per lui l’epilogo di oggi non sorprende. Era già stato scritto in nuce a metà degli anni sessanta. Glielo chiedo e conferma. “Sì. Ho passato metà della mia vita da dirigente Fiat lavorando all’estero e da lontano si osserva tutto con occhi molto più obiettivi.“
Il cerchio si sta chiudendo. Il pensiero non può che andare a mio padre e a un preconcetto che mi ha condizionato per anni: quello che la Fiat, gli Agnelli, la fabbrica, lo avessero solo sfruttato, rubandogli il tempo in cambio di una paga misera, di cassa integrazione a singhiozzo e di un perenne stato di incertezza. Forse non è andata proprio così. O forse la storia di Rocco non basta a definire la storia di una azienda. Definisce la mia.
C’è qualcosa nel tono di Pietro che evidenzia un aspetto che colgo solo ora. Il suo cerchio è chiuso da tempo, non ha nodi da sciogliere, domande rimaste inevase. L’attualità di Stellantis, l’agonia di Mirafiori, le strategia di Tavares non fanno parte del suo orizzonte. Lui è parte di qualcosa che è stato e che è, forse, irripetibile. Almeno non qui, non in tempi brevi.
“Ho molto amato la mia vita in azienda, è evidente. Sono entrato in Fiat che avevo i pantaloni corti. Mio padre temeva che finissi in fonderia, invece gli dissero che per me avevano progetti molto diversi. Alla scuola allievi sono stato formato per fare l’aggiustatore, il calibrista. Ho scoperto invece che il mio mestiere era quello del tracciatore. Sono diventato a mia volta un insegnante della scuola, quindi istruttore, poi caposquadra. Dopo il militare mi mandarono a tenere un corso al Lingotto, lì mi chiesero di entrare in produzione in fabbrica. Accettai subito e dopo poco mi offrirono di entrare nelle costruzioni sperimentali. Un sogno. Ed ero pure bravo, molto bravo. Sono diventato prima vice capo officina e poi, quando è iniziata la produzione della Lancia Delta mi chiesero di occuparmi della lastratura. Era l’anticamera dell’inferno, un lavoro durissimo. Avevo 36 anni ed ero già un dirigente. Con me c’erano 1600 operai da coordinare, il 30% erano donne e alcuni lavoratori la sera dovevano presentarsi alle autorità di Polizia. Per me è stata un’esperienza umana e professionale straordinaria. Certo poi c’è stata la parentesi delle Brigate Rosse, ma la salterei volentieri. Paura? Sì. Non avevo la scorta, ma non facevo mai la stessa strada per tornare a casa.”
Peccato non possa far leggere questa intervista a mio padre. Sono certo apprezzerebbe.
P.S. Pietro è un nome di fantasia. L’intervistato mi ha chiesto l’anonimato. Quando un cerchio si chiude, è chiuso. Gli sarò sempre grato per avermi raccontato la sua Fiat.
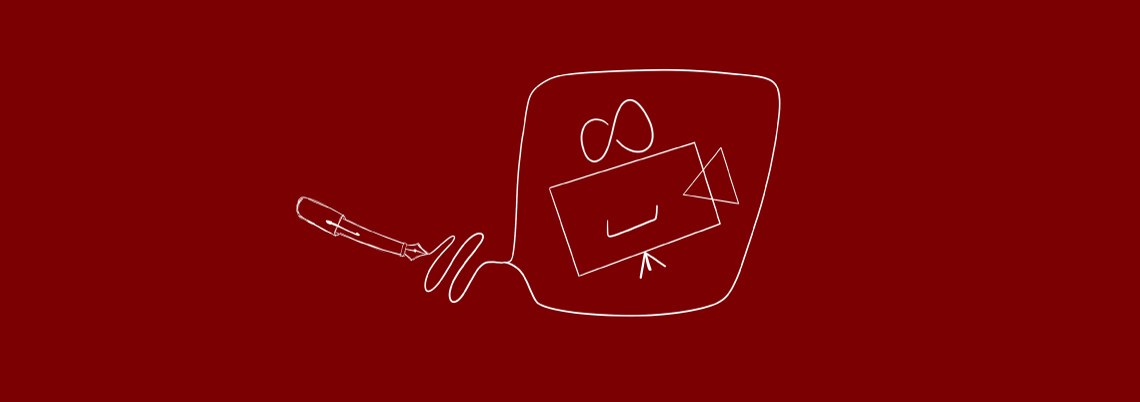

Bravo Sante, scrivi davvero bene! La Fiat per me era l’ ombra grigia su Torino, ma quel tuo Pietro le ridà qualche colpo di luce.
Grazie Silvio, detto da te vale doppio.